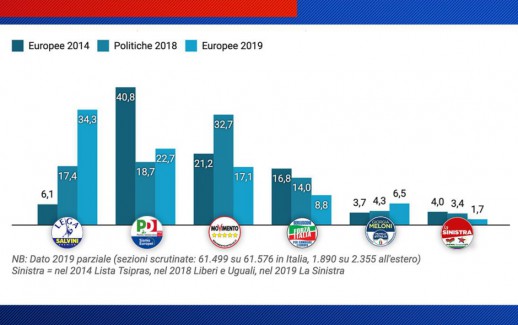António Costa: Rafforzare le politiche di coesione per un’Europa davvero unita nella diversità
Traduzione integrale, curata da Sara Ligutti, del discorso tenuto dal Primo Ministro del Portogallo, António Costa, alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni del 31/01/2018, più le successive repliche.
—
Signor Presidente del Comitato europeo delle regioni, caro amico amico Karl-Heinz Lambertz, care e cari membri del Comitato delle Regioni,
vorrei ancora una volta ringraziare questo Comitato che mi emoziona perché mi dà la possibilità di tornare in un’istituzione di cui sono stato membro per tanti anni e dove ho avuto la possibilità, non soltanto di lavorare, ma di stringere della amicizie che coltivo ancora oggi.
Sono entrato a far parte di questo comitato in quanto presidente della giunta municipale di Lisbona. Ed è qui che ho capito meglio qual è il ruolo centrale che Città e Regioni svolgono nella costruzione dell’Europa.
Sono le città, i territori a bassa densità, le regioni di montagna e le regioni ultraperiferiche che costituiscono il paesaggio unico dell’Europa. Sono queste che garantiscono all’Europa la propria identità. Queste sono le basi della principale ricchezza dell’Europa, che crea e consolida una cultura comune, dove i valori su cui si fonda la nostra Unione, sono forgiati e consolidati. Dall’antichità l’Europa è stata costruita dalle sue città e dalle sue regione regioni, che spesso hanno preceduto la formazione degli stessi Stati.
L’Europa si è riunita nella sua diversità applicando i principi di sussidiarietà e governance a diversi livelli, riconoscendo che ciascuno dei livelli – istituzioni europee, Stati membri, regioni, città, comunità locali – ha un ruolo insostituibile da svolgere per il successo delle aspirazionie legittime aspirazioni dei nostri cittadini.
La politica di coesione è la politica europea che ha maggiormente contribuito all’unità nella diversità dell’Europa. Gran parte del successo dell’Unione europea è dovuto alla sua politica di coesione.
Ed effettivamente la politica di coesione non si limita al suo contributo alla situazione economica e sociale dei nostri territori, ma corregge un po’ le asimmetrie tra i vari territori. Il suo più grande valore è quello di portare ogni giorno l’Unione Europea nella vita quotidiana dei suoi cittadini. L’Europa, con la politica di coesione, ha smesso di essere semplicemente una politica doganale, un insieme di norme tecniche del mercato interno. Con la politica di coesione, l’Europa ha raggiunto ogni villaggio, ogni città, ogni strada.
La politica di coesione è un marchio di identità dell’Unione europea, i cui obiettivi rimangono centrali oggi come quando è stata creata. Ecco perché la coesione non può e non deve essere la variabile di aggiustamento per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Piuttosto, dovrebbe avere una maggiore flessibilità nella sua definizione e implementazione, combinando il suo approccio territorializzato con una maggiore attenzione ai suoi principali beneficiari: le persone, i cittadini d’Europa.
Non dobbiamo cadere nella trappola della sterile dicotomia tra un’Europa della competitività e un’Europa della coesione. Garantire la competitività è la chiave per garantire una coesione sostenibile e quindi le due cose devono camminare mano nella mano.
Il futuro dell’Europa esige una società più coesa per un’economia più competitiva nel mercato globale.
Dobbiamo valorizzare la competitività delle aree a bassa densità di popolazione e rafforzare la coesione dei grandi centri urbani che concentrano grandi sacche di povertà. Il successo dell’Unione dipende dalla capacità di incrociare il meglio che ciascuno dei territori offre per lo sviluppo comune.
Per questo motivo difendo un’evoluzione della politica di coesione per rispondere alle aspettative dei cittadini nei contesti socio-territoriali in cui sono inseriti. La dimensione territoriale incentrata sul cittadino è oggi il modo migliore per rispondere alle nuove sfide che l’Unione deve affrontare.
Nel prossimo quadro finanziario pluriennale è importante agire in questa direzione, sfruttando le sinergie e le complementarità tra politiche e programmi, in particolare per rafforzare la competitività e la coesione.
Per affrontare le sfide della globalizzazione, una politica commerciale forte non è sufficiente, e forse ancora meno ricadere in una logica protezionistica. Dobbiamo investire nelle competenze, nell’innovazione e nelle infrastrutture che ci incorporano nelle reti globali. Solo in questo modo possiamo garantire una coesione sostenibile.
La concorrenza oggi non è tra le nostre regioni, i nostri comuni, le nostre città, ma tra l’Unione europea e le altre economie globali. Ecco perché non possiamo escludere dalla nostra politica regionale i centri di produzione della conoscenza, i motori della crescita e della creazione di posti di lavoro. Solo un’economia competitiva alimenta la coesione sociale e territoriale.
Solo allora la società europea diventerà più coesa e la nostra economia sarà più competitiva a livello globale.
È proprio questa complementarità che viene sintetizzata nell’obiettivo di convergenza. E la dimensione territoriale e la governance multilivello sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

Concordo con il parere di questo Comitato quando afferma che il valore aggiunto europeo dovrebbe avere come punto di partenza la correzione delle disparità socioeconomiche all’interno dell’Unione, ossia una convergenza reale.
Solo una maggiore convergenza darà una solida base al futuro dell’Europa.
La stessa Commissione europea lo riconosce nella sua comunicazione del 6 dicembre, che definisce la sua tabella di marcia per il completamento dell’Unione economica e monetaria: “Una delle lezioni della crisi [crisi economica e finanziaria internazionale iniziata nel 2008] è che la convergenza e la creazione di solide strutture economiche è fondamentale per la prosperità dell’Unione e in particolare per il buon funzionamento della moneta unica”.
Non possiamo posticipare ulteriormente questo dibattito. Questa è una finestra di opportunità: tutti gli Stati membri stanno attraversando un periodo di crescita economica, abbandonando le procedure per il deficit eccessivo e, soprattutto, creando posti di lavoro.
La crisi del 2008 ha esposto in modo decisivo i difetti congeniti di un’Unione economica e monetaria che ha creato più divergenza che convergenza tra i suoi Stati membri. Oggi siamo più preparati per rispondere alle nuove crisi. È vero.
Ma non illudiamoci: le debolezze strutturali dell’Eurozona rimangono irrisolte. Le asimmetrie e gli squilibri tra i suoi membri riducono la crescita potenziale e mettono a repentaglio la stabilità della moneta unica. Finché l’Unione economica e monetaria rimane incompleta, permangono i rischi di ulteriori crisi.
Se vogliamo una zona euro solida e stabile, dobbiamo rafforzare la convergenza economica e sociale, poiché non esiste una garanzia migliore per la sua sostenibilità.
Come disse il presidente Kennedy, ci sono giorni di sole, ed è in questi momenti in cui il sole brilla – non molto qui a Bruxelles, è vero – che dobbiamo cogliere l’occasione per completare l’unione economica e monetaria.
Per questo motivo difendo la creazione di una propria capacità di bilancio della zona euro, basata sulle risorse proprie.
Questo potrà servire come strumento di stabilizzazione contro gli shock esterni, ma il suo obiettivo primario dovrebbe essere l’investimento, dotando però di raccomandazioni specifiche ogni paese paese, consolidate nei programmi nazionali di riforma degli strumenti finanziari per la loro attuazione. Solo in questo modo il semestre europeo potrà essere pienamente al servizio degli obiettivi di crescita, occupazione e convergenza.
Non si tratta di difendere un’unione di trasferimenti o meccanismi di finanziamento per inefficienze nazionali. Non si tratta neppure di togliere qualcosa dalla politica di coesione per darla alla politica di bilancio. Sono due obiettivi separati ma complementari e dovrebbero essere inclusi nel prossimo quadro finanziario.
Come proposto da questo Comitato, ciò serve a garantire una maggiore coerenza ed efficacia delle nostre politiche macroeconomiche attraverso legami più stretti con il semestre europeo. Questi strumenti di politica fiscale, coordinati con la politica monetaria, permetteranno all’Eurozona di avere una vera politica economica integrata, unendo l’Europa, superando le divisioni tra Nord e Sud, Est e Ovest, centro e periferia.
Questi meccanismi di convergenza dovranno basarsi su una base contrattuale, al fine di attuare riforme destinate a rispondere alle necessità di ogni paese e definite da ogni paese in funzione della propria situazione specifica e che permettano di migliorare il loro potenziale di crescita, con obiettivi quantificati e vincolati a termini, debitamente finanziati.
Una condizionalità positiva, che opera attraverso incentivi piuttosto che meccanismi punitivi, è una condizionalità che sarà tanto più legittima se può disporre di una propria base di finanziamento.
Coesione, competitività e convergenza. Tre obiettivi che devono procedere di pari passo. Perché solo se vanno di pari passo contribuiscono a dare forza alla nostra Unione. E nella progettazione del prossimo quadro finanziario, avremo l’opportunità di utilizzare meccanismi per rafforzare questa complementarità e le sinergie tra le varie politiche.
L’Unione deve essere in grado di rispondere alle nuove aspirazioni dei nostri cittadini, alle nuove sfide: i cambiamenti climatici che minacciano l’umanità nella sua esistenza. La globalizzazione, che sfida la sostenibilità del modello sociale europeo. L’automazione che getta delle ombre sul futuro del lavoro. Le migrazioni che cambiano l’equilibrio delle nostre società. L’instabilità nei nostri territori limitrofi, che è un rischio per la pace. Il rischio del terrorismo che si diffonde anche nelle strade delle nostre città.
Sì, queste sfide esistono e dobbiamo affrontarle. Ma per rispondere efficacemente a queste nuove sfide, non dobbiamo né possiamo indebolire le fondamenta della nostra Unione, che si basano su politiche che hanno dato prova di enorme successo nell’ultimo decennio, come la politica agricola comune o la politica di coesione.
Se i cittadini europei chiedono più dell’Unione, gli Stati membri devono dare di più all’Unione. E per questo cerchiamo di essere chiari: non possiamo pensare di fare di più e fissare dei dogma per il bilancio dell’Unione, attenendoci soltanto all’1% del PIL di ogni paese. Non è possibile con l’uscita del Regno Unito mantenere lo stesso contributo da parte degli altri e al contempo fare di più senza sacrificare assolutamente niente di quello che già facciamo.

Cerchiamo di essere chiari: se vogliamo essere all’altezza di ciò che i cittadini europei ci chiedono, dobbiamo aumentare i contributi degli Stati membri o delle risorse proprie dell’Unione, come proposto dalla relazione dei 5 presidenti; oppure creare un equilibrio virtuoso tra l’aumento dei contributi degli Stati membri e la creazione di nuove risorse proprie per l’Unione.
D’altra parte, l’assunzione di queste nuove politiche per la sicurezza, la difesa e l’immigrazione non può costituire un impulso centralizzante, perché anche in questo caso il principio della governance multilivello è un valore aggiunto che deve essere preservato.
Gli obiettivi della coesione e della convergenza devono essere presenti non solo nelle nuove politiche, ma anche nei nuovi strumenti finanziari. Programmi chiave come Orizzonte 2020 o nuovi strumenti di finanziamento come il piano Juncker non possono comportare un aumento delle asimmetrie, ma devono incorporare i criteri di coesione e convergenza.
Per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di un’Unione forte che garantisca il rispetto globale dell’accordo di Parigi. Ma abbiamo bisogno delle collettività locali per promuovere la resilienza delle foreste e il loro ruolo di pozzi di CO2, e delle città per gestire una nuova politica di mobilità sostenibile.
Per quanto riguarda l’immigrazione, dobbiamo sviluppare un calendario di migrazione a livello dell’Unione per promuovere la cooperazione con i paesi di origine, se abbiamo bisogno di cooperazione tra gli Stati membri per proteggere le nostre frontiere esterne, è essenziale che le collettività locali garantiscano l’integrazione dei migranti nella nostra società.
Se la lotta al terrorismo richiede una maggiore cooperazione tra servizi di polizia, giudiziari e di intelligence, solo una forte politica di inclusione sociale impedisce la radicalizzazione nelle periferie o nei centri urbani impoveriti delle nostre città.
Se vogliamo mettere in atto il pilastro sociale che abbiamo adottato a Göteborg, dobbiamo avere autorità regionali e locali come attori chiave nella coesione sociale.
In altre parole, nessuna di queste nuove politiche può indebolire la coesione o il principio di governance a diversi livelli.
Al contrario, una maggiore coesione e convergenza sono una condizione per il successo in queste politiche e per dare risposte ai cittadini. Il caso più evidente è quello delle politiche migratorie. Se aumentiamo la convergenza economica e sociale all’interno dell’Unione, la pressione migratoria non si concentrerà più sulle regioni più ricche, sarà diluita e sarà possibile una gestione più efficace e solidale dei flussi migratori, con conseguenze molto positive per paesi come il Portogallo, che hanno bisogno dei migranti per contenere il loro declino demografico.
I negoziati per il prossimo quadro finanziario saranno impegnativi dal momento che dovranno misurare l’impatto della Brexit, mantenere le politiche strutturali di coesione e soddisfare le nuove priorità comuni come la sicurezza, la difesa e la gestione delle migrazioni.
Tutte queste sfide implicano che siamo innovativi e superiamo le divisioni interne, i limiti discrezionali e le ambizioni ridotte, inaccettabili di fronte alle responsabilità che l’Europa oggi ha nel mondo e nei confronti dei suoi cittadini. Non possiamo non affrontare in modo chiaro la questione delle risorse proprie.
Abbiamo un’ambizione e abbiamo delle politiche che abbiamo già visto che rispondono alle sfide che affrontiamo. Ora dobbiamo garantire i mezzi affinché queste politiche siano efficaci e ci consentano di essere all’altezza delle nostre ambizioni. Se vogliamo un’Unione più forte, più resistente alle crisi e più preparata alle nuove sfide, abbiamo bisogno di un’Unione con più risorse.
Oggi, la politica di coesione ha uno slancio unico che le consentirà, se forniremo gli strumenti e i mezzi appropriati, di realizzare completamente il proprio potenziale.
Da un lato, garantire la coesione interna delle nostre società, consentendo all’Unione di essere competitiva nel mercato globale. Ma anche per integrare il valore della coesione e della governance multilivello per migliorare il successo delle nuove politiche che l’Unione dovrà sviluppare, insieme e in modo inclusivo, con le istituzioni europee, gli Stati membri, e con tutta la diversità del proprio paesaggio.
Oggi e come sempre la nostra Europa sarà costruita soltanto nella diversità, nella diversità delle regioni montane, dei territori a bassa densità, delle regioni ultraperiferiche. Soltanto in questo modo faremo della nostra Europa un’Europa forte nella diversità capace di vincere le sfide di questo inizio del XXI secolo.
È per questo che è con molto orgoglio che sono nuovamente qui al Comitato delle Regioni ed è nella comunità delle Regioni che noi contiamo per costruire questa Europa del XXI secolo.
Grazie per l’attenzione.
—
Prima replica
È chiaro che abbiamo di fronte nuove sfide a cui dobbiamo rispondere. Dobbiamo rispondere alla sfida del terrorismo, una sfida che riguarda la nostra difesa comune. Dobbiamo rispondere alla sfida delle migrazioni. Ma se noi vogliamo che l’Europa costruisca questa sua nuova capacità, dovremo salvaguardare le basi solide su cui si basa, senza rendere fragili le istituzioni che già esistono. Per questo è fondamentale salvaguardare le due politiche che hanno dato prova migliore durante gli anni e che costituiscono l’identità dell’UE: la PAC (Politica agricola comune) e la politica di coesione. E dobbiamo completare l’unione monetaria Se vogliamo salvaguardare e consolidare quello che è stato il progetto più ambizioso realizzato dall’Europa fino ad oggi. E questa è una buona occasione per farlo. Perché ci troviamo a lottare contro il tempo, possiamo approfittare proprio di questa finestra di opportunità.

Secondo, le nuove politiche non posso essere un pretesto per centralizzare, ma al contrario devono essere uno strumento per rafforzare la governance a vari livelli. Noi vogliamo avere una buona politica migratoria, per questo dobbiamo rafforzare il ruolo delle comunità locali nella politica d’integrazione. Se vogliamo prevenire attivamente la radicalizzazione dobbiamo avere più inclusione sociale. E per questo dobbiamo avere maggiore partecipazione delle collettività locali.
Se vogliamo addirittura rispondere alle sfide del cambiamento climatico, abbiamo bisogno di nuove politiche di comunità: soltanto chi amministra attivamente le città è in grado di fare in modo che le politiche di mobilità vengano gestite in modo diverso […]
Dobbiamo sicuramente coinvolgere maggiormente il Comitato delle Regioni. […]
Vorrei rispondere alle domande fatte.
Le regioni ultra-periferiche sono parte fondamentale della nostra Unione. Sono le regioni ultra-periferiche che ci danno una dimensione globale. Senza la proiezione atlantica delle Azzorre, di Madera, l’Europa non avrebbe le dimensioni che ha. Senza la proiezione extraeuropea di altre regioni ultra-periferiche, l’Europa non avrebbe le dimensioni che ha. E se vogliamo avere oggi un ruolo globale, dobbiamo valorizzare questo ruolo svolto dalle regioni ultra-periferiche che ci aiutano, appunto, a rappresentarci nel mondo globale.
Dobbiamo rafforzare gli strumenti relativi alla protezione civile, ma dobbiamo anche migliorare il grado di protezione sia delle foreste sia delle infrastrutture che abbiamo, per far fronte ai rischi esistenti. Non c’è società senza rischio, dobbiamo aver conoscenza e consapevolezza del rischio. E i cambiamenti climatici non sono cose solo teoriche, che toccheranno alle prossime generazioni, ma riguardano oggi le nostre coste, le nostre foreste, si manifestano già oggi nella bassa qualità dell’aria in molte città. Per questo è importante agire adesso per rispondere a questa realtà. […]
Per quanto riguarda il piano di ricollocazione dei migranti, il Portogallo è favorevole. Il Portogallo non è per ragioni geografiche in prima linea relativamente ai flussi migratori. Se vogliamo avere un’Unione più forte dobbiamo essere capaci di condividere. Sia la prosperità gestita da questa Unione, che le responsabilità derivate da questa Unione. E una di queste responsabilità è quella che abbiamo nel garantire la protezione internazionale a chi merita questa protezione internazionale. Questo compito non può essere lasciato sulle spalle della Grecia, dell’Italia, di Malta, dei paesi che si trovano in prima linea. E questa responsabilità non può nemmeno ricadere soltanto sui Paesi che sono più sviluppati, come la Svezia e la Germania. […]
Il Portogallo vuole assumersi le sue responsabilità e per questo si è sempre dichiarato disponibile ad avere una quota superiore di migranti che la divisione matematica ci ha attribuito. […] Dei 10000 posti offerti da noi, sono solo 1500 le persone che sono state ricollocate in Portogallo. E alcune di queste se ne sono andate. […]
Dobbiamo rafforzare la convergenza perché le opportunità siano più condivise, non soltanto a beneficio di ogni Stato membro, ma perché vogliamo essere più efficaci nello sforzo di ricollocazione.
—
Seconda replica
[…] In primo luogo, è vero che continuo a essere entusiasta sulle capacità delle Regioni e dei poteri locali. Effettivamente ho cambiato funzione, ma non ho mutato d’idee. Quello che ho appreso in quanto sindaco di Lisbona, l’ho appreso qui nel Comitato delle Regioni. […]
Se vogliamo un’Europa unita dobbiamo avere un contatto con le sue regioni e con i suoi enti locali. […] La politica di coesione non si limita a correggere le disuguaglianze regionali, la politica di coesione ci ha aiutato a trasformare l’Unione Europea in qualcosa che è legato alla vita quotidiana di ogni cittadino. Dobbiamo avvicinare i cittadini all’Europa. E per questo la politica di coesione ha un ruolo essenziale.
Non ho dimenticato neppure l’importanza della governance multilivello. Ho citato vari esempi, come appunto i cambiamenti climatici, le sfide concrete di sicurezza che si presentano quotidianamente e che richiedono, appunto, questa governance multilivello, che non è solo necessaria, ma è anche un plusvalore affinché la politica di coesione sia efficace.
Qualcuno mi ha chiesto per esempio che contributo possiamo dare nella prevenzione della radicalizzazione. C’è qualcosa che dobbiamo ascoltare, vedere e verificare. Fino ad oggi in tutti gli attentati terroristici, i terroristi non sono mai venuti da fuori del territorio europeo, ma sono stati radicalizzati all’interno dell’UE. Sono stati radicalizzati per cause comuni, per mancanza d’inclusione sociale, che porta molte persone a cercare altre forme d’inclusione e che costituiscono un fenomeno catalizzatore che molto spesso porta alla radicalizzazione. […]
I programmi di rigenerazione urbana e d’inclusione sociale che devono essere sviluppati a livello locale sono assolutamente essenziali per avere una capacità effettiva di arrivare e prevenire la radicalizzazione. E questo non è un’alternativa alla cooperazione delle autorità giudiziarie, ma è un buon esempio di come la governance multilivello possa essere assolutamente essenziale e dare un contributo efficace. […]
Naturalmente è necessario che ci sia un dialogo effettivo fra i governi nazionali e le collettività regionali e locali.
Nella messa a punto della strategia post-2020, in Portogallo abbiamo avviato già in giugno un dialogo a livello di Consiglio, di concertazione territoriale e la settimana scorsa il dialogo abbiamo portato il dialogo a ogni livello di giunta regionale. Adesso ci stiamo confrontando con le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, per avere una strategia che non sia solo quella del governo, ma che veda anche la partecipazione degli enti locali e regionali.
Il processo del Portogallo è un processo che dovrebbe essere seguito in ogni Stato membro per fare in modo che la strategia sia veramente nazionale e non semplicemente del governo, che veda la partecipazione di tutti i livelli di amministrazione […].
Vari colleghi hanno fatto la stessa domanda. Abbiamo una ripresa, ma questa ripresa è disuguale e ci colloca davanti alla questione centrale della convergenza. E qui ci sono due aspetti fondamentali.
Uno, a cui si è fatto riferimento adesso, […] che ha a che fare con i nuovi strumenti del piano Juncker.
Il piano Juncker è effettivamente un plusvalore. Ma perché non sia uno strumento che accentua le asimmetrie tra le varie regioni, deve avere un modo di applicazione che porti dei vantaggi […] e non escluda quelle regioni a bassa densità.
È lo stesso quesito che si pone per quanto riguarda il modello economico e monetario. Sappiamo tutti che l’unione economica e monetaria, se non avrà dei fattori correttivi, non rafforzerà la coesione, ma al contrario, accentuerà le asimmetrie. […] È fondamentale introdurre in questa riforma economico-monetaria una capacità di convergenza. […]
[…] Per risolvere questi problemi […] dobbiamo avere uno strumento per la convergenza. Se è a livello dell’Unione tanto meglio, se è intergovernativo, va bene, è comunque meglio di niente. […]
Volevo anche rispondere ad altre due domande che sono state poste.
Primo: parità di genere. La parità di genere dev’essere una priorità trasversale in tutte le politiche dell’Unione. Non è semplicemente una questione istituzionale. Ecco perché la necessità del pilastro sociale della UE, i cui principi fondamentali sono stati recentemente adottati a Göteborg. Dal principio dobbiamo però passare al piano d’azione e dal piano d’azione alla realtà. E questo è un lavoro che deve essere fatto.
Per quanto riguarda i giovani, l’Europa non può perdere l’attuale generazione. Per questo dobbiamo andare al di là della semplice Garanzia Giovani, dobbiamo potere investire maggiormente nell’economia, un’economia più dinamica, per includere meglio questa nuova generazione, dove il tasso di disoccupazione è spaventoso. Stiamo creando in questo modo un gap generazionale che non ha un impatto solo sul presente, ma avrà un impatto anche sul futuro, soprattutto con le pensioni. Questa quindi deve essere una priorità massima.
Da ultimo, e questo è l’elefante nella stanza. […] Capisco quando dite che non volete più imposte, ma qualcuno nel mondo vuole forse pagare più tasse? Ovvio che nessuno vuole pagare più tasse, però la cosa che dobbiamo chiederci è questa: non c’è stato qua nessuno in sala che dicesse che bisogna diminuire le politiche di coesione. Tutti vogliono mantenere o persino rafforzare le politiche di coesione. Non ho sentito nessuno dire che dobbiamo ridurre la PAC, anzi, tutti diciamo che dobbiamo mantenerla. Nessuno qui ha detto che non dobbiamo investire più nella difesa, nella lotta contro il terrorismo, nel gestire meglio le nostre frontiere esterne o per accogliere meglio i nostri migranti. Tutti abbiamo parlato di cose che implicano più spese. Ma se abbiamo più spese, come possiamo sostenerle se non abbiamo più bilancio?
Quindi, nella massima serietà, devo dire che noi non stiamo togliendo qualcosa agli Stati per darlo all’Unione, noi abbiamo l’Unione perché riconosciamo che quello che dobbiamo fare oggi per i nostri cittadini, in molti ambiti può essere garantito meglio a livello dell’Unione che non a livello di ciascuno Stato. […] Quando centralizziamo delle competenze per una regione o per un municipio è perché pensiamo che quello è il livello in cui possiamo essere più efficaci nell’attuazione di una certa politica. Anche in questo caso non togliamo nulla ai cittadini, poniamo solo risorse al livello adeguato, in modo tale da avere il massimo risultato. […]
Ci sono ad esempio delle attività economiche oggetto di grande evasione fiscale, proprio perché è difficile individuare i casi a livello nazionale. Tutti gli Stati, con rarissime eccezioni, si lamentano perché hanno grosse difficoltà nell’individuare i casi di violazione da parte delle grandi imprese multinazionali. Queste imprese digitali naturalmente sono al livello del “cloud”, quindi sono difficili da identificare. Ma è molto più facile individuarle a livello della UE, perché l’Unione ha molto più potere che non ciascuno Stato membro isolatamente […].
Ecco perché l’Unione ha, per i nostri cittadini, un plusvalore rispetto a ciascuno Stato membro. Quindi noi crediamo in questo, investiamo in questo, investiamo nell’Unione. […] Vogliamo un’Unione più forte in modo tale da poter rispondere con maggiore efficacia e vicinanza alle esigenze dei nostri cittadini. […]
—
(Tutte le foto di European Union / Patrick Mascart)