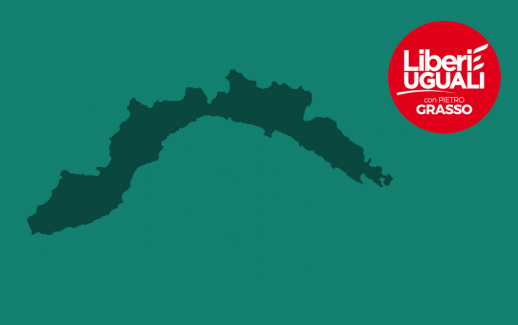Sinistra Anno Zero. Il discorso di Giuseppe Provenzano
Sabato 7 aprile si è svolta a Roma l’iniziativa “Sinistra Anno Zero”. Dieci ore di assemblea con decine di interventi di giovani e meno giovani, militanti e studiosi, studenti e pensionati. L’Argine, oltre al video di Radio Radicale, vi propone la trascrizione integrale del discorso di Giuseppe Provenzano (LEGGI ANCHE: Sinistra. Chi è Peppe Provenzano?).
Il video del discorso
SINISTRA ANNO ZERO. Il discorso completo di Peppe Provenzano
Siamo arrivati qui da percorsi diversi, da correnti diverse, da partiti diversi o da nessun partito. È questo forse è anche più bello. Tutti mossi da un’urgenza, da una comune preoccupazione. Peggio della sconfitta, molto peggio della sconfitta, è la reazione alla sconfitta. Il 4 marzo ha segnato il punto più basso delle forze di sinistra non solo della storia della Repubblica, ma da quando esiste il suffragio universale maschile. Per trovare un risultato peggiore, bisogna risalire a un tempo buio. 1924, prime elezioni con il listone fascista, legge Acerbo. Scusate se, difronte a questo, non ci occuperemo delle dinamiche interne del Pd. Lo dico ai giornalisti. Questa non è un’assemblea della minoranza. Certo, il Pd ci interessa. Ci preoccupa, soprattutto. L’ultima Direzione è stata surreale. Hai dimezzato i voti, sei sparito da intere aree sociali e geografiche. Ma ti vuoi chiedere perché? Puoi anche litigare, discutere, romperti la testa. Macché, niente. Poiché Renzi si era dimesso non si poteva discutere di Renzi. Per non irritarlo. Alcuni si cimentavano coi problemi della sinistra in Europa, coi contraccolpi della globalizzazione… era la prima volta per molti di loro quindi c’è stata una bella fiera della banalità. Ci mancava solo che qualcuno tirasse fuori le congiunture astrali per spiegare la sconfitta, e il catalogo degli alibi era perfetto. Nessuno di noi ha voglia di parlare del renzismo e dei gigli vari. Avremmo preferito non parlarne più. Ma visto che, dopo la farsa delle dimissioni, sono ancora lì come se nulla fosse, servivano ancora parole chiare. Ho provato a dirle. A dire che gli elettori hanno rigettato in modo inappellabile, il 4 dicembre 2016 e il 4 marzo 2018, una leadership e un modo di gestire il potere che ha fatto ombra anche alle luci dell’azione di governo. Cioè che quel gruppo dirigente ha rotto con il popolo della sinistra. Ci sono ragioni profonde, ma poi, come in tutte le storie che finiscono male, ci si ricorda una frase, una parola, un gesto.
Se sei il capo di un partito di centrosinistra, che Marchionne è meglio dei sindacalisti, non solo non lo puoi dire perché è falso, ma proprio non lo puoi dire.
Se sei un leader inviso agli italiani, plasmare il partito a tua immagine e somiglianza, da ultimo in liste compilate in maniera padronale, è l’errore politico definitivo. Se hai sbagliato così forte, ora ti fai da parte. Ma non saremmo onesti se riducessimo a Renzi il divorzio tra elettori e sinistra. Ha riguardato un’intera classe dirigente, e in modo quasi spietato i protagonisti della sinistra nella Seconda Repubblica. Dal tacco dello Stivale al suo cuore rosso, dove il padre nobilissimo dell’Ulivo ha benedetto una lista dello zero virgola. I gruppi dirigenti sono però solo un aspetto del problema. Non è questo che ha portato la sinistra all’anno zero. Capiamoci, l’anno zero non esiste. Nei fatti umani non esiste tabula rasa. Spesso invece ci sono macerie, da scansare. Come in questo caso. Dove non basta una semplice ristrutturazione, bisogna ricostruire dalle fondamenta il campo della sinistra. Oggi, tutti quelli che si dichiarano di sinistra, e per me vale l’autocertificazione (chi si dice di sinistra già va bene, siamo messi così male che non possiamo fare troppo gli schizzinosi!), hanno una comune preoccupazione: un sistema americanizzato, in cui la sinistra vive magari in qualche pezzo di sindacato, nella buona cultura di qualche università o fondazione filantropica, ma non è un’opzione politica, non è più una vera alternativa di governo.
Noi pensiamo che si debba ridiscutere quello che siamo stati non negli ultimi cinque anni, ma negli ultimi venticinque. In questo arco di tempo si è consumata la rottura.
Si è detto che le culture fondanti della Repubblica sono uscite sconfitte dalle urne. La notizia è alquanto datata. Cosa era rimasto, in noi, di quella straordinaria visione, del rapporto tra economia e Stato messa in campo dalla sinistra cattolica, dal Codice di Camaldoli in poi? Cosa è rimasto dei costruttori dell’Italia? Dei Vanoni, degli Enrico Mattei? Cosa è rimasto della capacità di governo di laici come Ugo La Malfa? Cosa è rimasto del riformismo sociale del sindacato dei Di Vittorio? Cosa è rimasta di quella opera impagabile di alfabetizzazione democratica, di “costruzione” del popolo, dei socialisti e dei comunisti italiani? Nulla. Non è rimasto nulla. Non abbiamo perso oggi. Noi vogliamo tornare a prendere l’acqua al pozzo, per citare quel proverbio cinese caro a Macaluso. Machiavelli nei Discorsi dice che “a volere che una religione o una repubblica viva lungamente è necessario ritirarla spesso verso il suo principio”. Qui dobbiamo chiarirci. Il principio, sia chiaro, non è lo “spirito originario” del Pd. Un partito nato con un po’ di Scoppola, un po’ di Reichlin, e via, dai pantheon agli incarichi. Un partito per cui andavano bene sia Boccuzzi che Calearo (se non ve lo ricordate, è giusto così). Tutto questo, nel momento in cui esplodeva la crisi peggiore della nostra storia. Fateci caso, nei nostalgici dello spirito originario, non compare mai la parola: crisi. Mai.
Il Pd è nato tardi, s’è detto. No, è nato vecchio.
In un mondo stravolto sotto i colpi della Grande recessione. L’unico ancoraggio sociale, la classe media, in pochi anni sarebbe venuta meno. Al punto più basso della famosa “curva dell’elefante”, che racconta i vincenti e i perdenti della globalizzazione, c’era il nostro mondo. La crisi vi ha aperto una voragine: e tutta la mitologia fatta di ulivi e di euro, di primarie e ceti medi riflessivi, di civismo e buon governo cittadino, ci è finita dentro. Ci è finito dentro il Pd, con tutti i cascami della sinistra della Seconda Repubblica. E qui c’è la peculiarità italiana. S’è detto, quasi fosse una scusante, che la sinistra perde in tutta Europa. A parte il fatto che non è vero, penso alla Grecia, al Portogallo, al Labour che ha più del doppio dei nostri voti e spesso detta l’agenda politica inglese, c’è un dato che fa riflettere: laddove perde la sinistra “riformista”, si affermano sinistre “radicali” – è il caso della Spagna, ad esempio, di Podemos, che non è come il M5S e il suo leader non è Di Maio; ma è anche il caso della Francia, e così via. Poiché nulla di nuovo è nato, dobbiamo interrogarci su quello che siamo stati, sulle parole che abbiamo detto, sulle cose che abbiamo fatto e soprattutto quello che non abbiamo fatto negli ultimi decenni, non nelle ultime settimane. Ringrazio Maurizio Martina di cuore di essere qui, e spero che non gli abbiamo creato troppi problemi e, anzi, gli faccio un grande in bocca al lupo. Ma se qualcuno vuole sentire quello che alcuni di noi faranno all’Assemblea del Pd, ha davvero sbagliato sala. Non lontano da qui c’è Richetti: Harambee! Noi abbiamo un programma fitto di lavori. Proveremo ridiscutere di Europa e Mondo, di Stato e mercato, di welfare, lavoro e sindacato. E parleremo della politica – e della libertà, della democrazia: non solo dell’industria e del lavoro – al tempo dell’algoritmo, della rivoluzione digitale. Provo a dire la mia. Se non saremo d’accordo, meglio. Dopo il 4 marzo, credo ci sia bisogno proprio di questo, di chiarezza. Io penso che ci siamo accorti tardi della Grande recessione economica, e ancora più tardi della recessione democratica. C’è chi l’ha chiamata: la Grande regressione. La democrazia si rattrappisce dove aveva le radici più antiche. Il gioco delle potenze vede vecchi e nuovi autoritarismi. Nella post-democrazia la concentrazione di potere privato fa saltare ogni compromesso con il capitalismo. Un’infrastruttura enorme, come il web, nelle mani di pochi. Google, Facebook. Non ci sono precedenti nella storia dell’umanità. Altro che socialismo, basterebbe un po’ di liberalismo in questi casi. L’apertura dei mercati ha contribuito sì all’uscita dalla miseria e dalla povertà di milioni di persone, ma tra i “paradossi” della globalizzazione vi è che la velocità di conquista dei diritti sociali e civili nei capitalismi che emergono è generalmente minore di quella in cui nei capitalismi “avanzati” li perdono i lavoratori, già ceto medio, spesso nuovi poveri.
La destra ha una sua risposta. Ripiega nella difesa dei confini, di ideali regressivi, persino della razza: vendendo alla popolazione un’illusione di protezione. E la sinistra? Non offre protezione sociale ma un ottimismo idiota contro cui ci vorrebbe Voltaire a dire che questo “non è il migliore dei mondi possibili”.
Guasto è il mondo. Prendiamo gli ultimi giorni: l’assassinio di Marielle Franco, combattente nelle favelas per i diritti, la storia di una compagna che trafigge il cuore; l’orrore di Afrin, perpetrato da quella Turchia del nuovo sultano, il gendarme che l’Europa finanzia senza vergogna; l’arroganza nazionalista della Francia a Bardonecchia. Fatti che sembrano trascendere le nostre forze, il nostro potere. Ma questo non può diventare l’alibi per la nostra indifferenza. Da quando un partito di sinistra non organizza una manifestazione sul mondo? “Se noi taceremo, grideranno le pietre”. Il nostro balbettio è iniziato di fronte ai movimenti per un’altra globalizzazione, che spesso avevano molte più ragioni della Terza Via. Civilizzeremo la globalizzazione, ci dicevamo. Certo, a farlo, non saranno i cittadini: dovrà essere una élite illuminata, cosmopolita. Solo che nel frattempo, qualcuno ha detto al popolo: se non ci sono regole, meglio il protezionismo. E nella disgregazione sociale maturava l’insofferenza per la democrazia.
Avevamo rinunciato all’ambizione di cambiarlo, il mondo. Ma prim’ancora di interpretarlo. E questo ci ha privato di identità, di funzione, di potere. Avremmo avuto bisogno di una sinistra che facesse il suo mestiere: combattere le disuguaglianze e le solitudini, redistribuire potere e rappresentanza.
Con strumenti nuovi, certo. Ma alcuni strumenti vecchi, che avevamo usato poco e male, non erano da buttare: la progressività delle imposte, il welfare. Noi pensavamo ai diritti. E più a quelli civili (ci sono storie di amore, di sofferenze indicibili, non voglio essere frainteso). Bene, benissimo. Meno bene è stato fermarsi non appena quei diritti si tingevano di una qualche sfumatura sociale, come sullo ius soli. Il fatto, però, è che accanto ai diritti erano tornati i bisogni. E noi nemmeno li riconoscevamo più. Erano esplosi con la crisi ma la ripresa li lasciava intatti, allargando i divari: tra i cittadini, tra le imprese. Una minoranza ce la faceva per tutti, la media cresceva, ma la maggioranza non vedeva vie d’uscita. Avremmo avuto bisogno di ricostruire lo Stato, le istituzioni, dare ad esse credibilità, forza, capacità di incidere, migliorare la vita delle persone. Farlo in Europa, certo. Ma se l’Europa non lo fa? L’eccesso di zelo nella ricerca delle “compatibilità” ci ha fatto perdere di vista ogni interesse nazionale. L’ideologia del “vincolo esterno” – che è stata cara anche alla meglio classe dirigente della sinistra – ha diffuso sfiducia in noi stessi e si è risolta nel suo contrario: ha finito per deresponsabilizzare non solo i cittadini ma anche le classi dirigenti. Se, nel governare, metti il “pilota automatico”, se a scegliere non sei tu, a che servi? A cosa serve la politica? Tutto questo ha privato l’Europa di uno spazio di conflitto politico, e ha privato di ruolo la sinistra. La crisi ci restituiva un’Europa divisa, rivelando nel volgere di pochi anni, dalla vicenda greca (in cui c’è stato il primo suicidio della socialdemocrazia) a quella dei migranti, le falle di una costruzione non “incompiuta”, ma segnata da un’impronta sbagliata, di “strutturale” indifferenza alle disuguaglianze, agli squilibri.
La sinistra ha fatto dell’Europa una retorica vuota. Si sventolava il Manifesto di Ventotene – fino alla vergogna di celebrarlo su una portaerei – senza averlo letto. L’Europa “dovrà essere socialista”, c’è scritto.
Era questo il nostro “Più Europa”? Temo di no. Questo significherebbe per la sinistra rinunciare alla prospettiva europea? Significa esattamente il contrario. Significa che la sola strada per la sinistra, da percorre da qui alle elezioni europee dell’anno prossimo, è una battaglia chiara, forte, per la modifica della costituzione economica dell’Europa. Perché così la costruzione di un’Europa sociale è solo un castello di carte a Bruxelles. Di questo dovremmo discutere con Macron, guardando i rapporti di forza reali. Anche se credo non saremo d’accordo. Bisogna aprire una discussione seria, razionale, pacata, sulla sostenibilità di un’Europa tedesca. Sulla moneta che penalizza i deboli e favorisce i forti, senza lo scettro, senza l’armonizzazione dei sistemi fiscali. Sulle banche e sul debito. Porre il tema della frontiera meridionale, del Mediterraneo come scenario ben oltre la gestione vergognosa dell’emergenza migranti, come scenario: dalla Via della Seta alle sfide energetiche. Altro che sbattere i pugni sugli zero virgola. Specialmente se poi, dici di batterti contro l’austerità, e usi la “flessibilità” per abbassare le tasse ai ricchi, per i bonus ai diciottenni pure ai figli di Marchionne.
Ci siamo fatti scavalcare a sinistra perfino dalla Commissione europea. Dal Fondo monetario internazionale. Da tutti.
Gli editorialisti economici no, quelli sono rimasti a vent’anni fa. Abbiamo portato gli investimenti pubblici al livello più basso di sempre. Ma cosa parli di futuro? Come lo costruisci uno Stato intelligente, strategico, innovatore? Lo Stato regolatore, non basta più. In tutto il mondo lo sanno e non hanno mai smesso di fare quelle politiche industriali che, da noi, fino a ieri l’altro erano una bestemmia. Abbiamo ammassato un intero armamentario di strumenti di intervento pubblico nell’economia in un grande magazzino chiamato Cassa depositi e prestiti, e nessuno sa quello che fa. Le poche grandi aziende partecipate rimaste come promuovono lo sviluppo economico del Paese? Se non la fa la politica questa discussione, la fanno gli altri centri di potere. L’hanno fatta altri centri di potere. Il grande tema della ricerca pubblica, del trasferimento tecnologico? Io ho proposto: sblocchiamo interamente il turn over e facciamo entrare mezzo milione di giovani nel settore pubblico. Ci si poteva fare la campagna elettorale, su questo. Riapriamo i concorsi. Non è assistenzialismo, è il contrario. Basta luoghi comuni. Rispetto ai grandi Paesi europei, con cui dovremmo competere, abbiamo la Pubblica amministrazione più piccola, più vecchia e più povera di competenze. Se i laureati sono meno di un quarto, chi è in grado di orientare le trasformazioni del modello di sviluppo, l’innovazione? Chi si occupa della digitalizzazione di 8.000 comuni: 32 persone in un ufficio a Palazzo Chigi? Ma non prendiamoci in giro. Abbiamo ancora quasi due milioni di giovani occupati in meno rispetto a prima della crisi: quel disagio lo avevamo visto al referendum. Ma noi cosa gli dicevamo? Che il lavoro è ripartito, grazie al Jobs Act? L’occupazione si è spostata sulle fasce anziane per la Fornero. Crescere il lavoro di bassa qualità e il part-time “involontario”. L’impresa ha goduto della decontribuzione, ma ha assunto a tempo ridotto, e quindi a salario ridotto. Altro che conciliazione dei tempi di vita. Non è stata una scelta e nemmeno un disegno strategico, su cui vogliamo discutere (la Germania l’ha fatto con l’ultimo accordo dei metalmeccanici). Forse è tempo di redistribuire l’orario di lavoro. Oggi il rischio è di una divisione tra un’umanità di serie A inserita nei processi produttivi e un’umanità di serie B che li subisce, e che magari riesce a consumare perché riceve il Reddito di cittadinanza. Interroghiamoci, con le imprese, con il sindacato. Che va sfidato a cambiare, certo non facendogli la guerra. Perché la sinistra, senza un sindacato forte, semplicemente, non esiste in natura. La Cgil ha aperto un congresso difficile, a cui dovremmo guardare con attenzione. Partecipare. Qua non lo dice più nessuno, io lo dico soprattutto ai miei amici più giovani: iscrivetevi al sindacato. Facciamo una battaglia per portare i lavoratori nei CdA delle grandi aziende! Impossibile? Intanto facciamolo con le aziende pubbliche. Invece di dare noi, come spesso abbiamo fatto, un triste spettacolo di lottizzazione che non è nemmeno più partitica o correntizia, risponde ad altri centri di potere.
E poi basta, basta, con la stupidaggine che, se non hai il lavoro, ti metti in un garage e te lo inventi come fossero tutti Steve Jobs. Basta.
Start-up, innovazione… La parola “innovazione”, sulle nostre bocche, sembrava la “distruzione creatrice” di Schumpeter: noi stavamo lì e guardavamo compiaciuti. Aveva perso ogni sensibilità sociale. E invece è questo che dobbiamo ritrovare ogni volta che parliamo di innovazione. Perché l’innovazione può migliorare la vita delle persone, come la mano artificiale che fanno a Pisa per chi ha perso la funzionalità degli arti: questo, contro ogni nuovo oscurantismo, è quello dobbiamo chiedere alla scienza. Come migliorare il lavoro. Come gli includere gli esclusi, nei centri di eccellenza e nelle periferie. Il problema non è tornare al popolo; il problema è anche cosa gli dici, al popolo. Che gli dici? Che il tuo capo ha amico che si chiama Elon Musk e che fra vent’anni, tu, se hai soldi, ti porta a fare un giro su Marte? Se c’è un bisogno di protezione, vuol dire che la sinistra non fa il suo mestiere. Vuol dire che i servizi non funzionano: scuole, sanità, assistenza. Ma anche l’illuminazione delle strade, controlli e sicurezza. E se la cosa pubblica non mi protegge, a che serve? È solo un costo. Oppure, nella variante di destra, perché devo pagare le tasse? Anche qui, “troppo poco e troppo tardi”.
Il Reddito di inclusione – una misura che esiste in tutta Europa – è arrivato solo quest’anno. Ma se l’avessimo finanziato per tutti, magari rifacendo pagare le tasse sulle case dei ricchi, avremmo fatto una cosa giusta e tolto un’arma agli altri.
Perché se vi accedono solo un terzo dei poveri, agli altri due cosa gli racconti? Che si facciano la guerra tra ultimi e penultimi? Attenzione, perché questo è il meccanismo che ha reso gli ultimissimi – che sono per definizione, gli altri, gli stranieri, i profughi – il capro espiatorio perfetto di ogni malessere sociale. Perché cosa predichi l’integrazione, l’inclusione, se hai uno Stato “spappolato”, e se questo si scarica sui sindaci e sui Comuni che non possono ristrutturare alloggi, offrire servizi sociali degni di questo nome ai propri cittadini. E magari è lì che piazzi pure il centro migranti. I flussi migratori sono la sfida del nostro tempo. Ma allora non la si può lasciare al Ministro dell’interno. Tra l’emergenza democratica e l’appello spesso moralistico all’accoglienza, ci dev’essere lo spazio per una sinistra che voglia gestire il fenomeno. Anche su questo misuriamo la distanza tra l’Europa immaginata e risuonano ancora le parole del Papa a Lampedusa. Ma, lo dico con rispetto, una sinistra potrebbe anche chiedere alla Chiesa di far mettere il preservativo in Africa, perché l’esplosione demografica non è solo un rischio per le nostre democrazie, ma per la stessa vita del pianeta. Se sei la politica, non puoi dire che tutto ciò che è reale è razionale. Che c’è la globalizzazione, che c’è la rivoluzione tecnologica, che c’è la crescita demografica in Africa. E allora tu ti devi rassegnare, tu devi dire è così. Perché poi vince quello che ti dice: io mi chiudo a chiave. Se vuoi offrire un’alternativa, hai bisogno di un pensiero alto, sulla demografia, su Nord e Sud del mondo, sulle nuove geografie dello sviluppo, sulla sopravvivenza del pianeta, sulla guerra e sulla pace. Da quanto tempo ci manca?
Da quanto la sinistra non organizza cultura e discussione pubblica? Sbuffando “che palle” davanti a questa responsabilità abbiamo perso il popolo. E siamo arrivati alla disintermediazione che è stato il nostro colpo di grazia.
Lo so cosa diranno, questa è la vecchia sinistra. Sono loro che cercavano il nuovo ad aver trovato il vecchio. E a volte il vecchissimo: trasformismi, consorterie, provincialismi! Ma solo nella provincia fiorentina davano credito credito a Blair! Conosco l’obiezione: il popolo non vuole “più sinistra”, altrimenti avrebbe votato LeU. Lo dico con rispetto: se vuoi fare Corbyn, non dico che devi proprio essere Corbyn, ma almeno devi avere un minimo di credibilità. Dicono: non serviva più sinistra. Be’, per esempio nel Lazio la sinistra è servita, e dividerci è stato un errore storico. Quella divisione è una ferita da sanare, non per i gruppi dirigenti, lo dico per una generazione che oggi è qui, a discutere con naturalezza, e non c’è nessun motivo per cui sia divisa. Ma questo passa da un chiarimento di fondo, urgente e definitivo: nel Pd, oggi, c’è ancora spazio per la sinistra? Non in astratto, per le cose che stiamo dicendo. C’è spazio? Non mi riferisco alle prospettive macroniane, mi riferisco a quello che siamo stati fino ad oggi, un partito “pigliatutto”, piazzato al centro. E questo a cosa è servito? Dicono: non serve la sinistra… qui è crollato il centro! La Bonino cercava i voti di Monti e quei voti sono andati ai 5S. Oggi, la cosa che più somiglia a un nuovo centro, se guardiamo, non alle idee ma alla base sociale del consenso, è il M5S. Poi, come sempre, il Dio acceca quelli che vuole perdere, perché questi annunciano la prospettiva macroniana, in chiave antisovranista, proprio il giorno di Bardonecchia. Poi c’è un sottosegretario che ci dice: oh, dobbiamo fare l’alleanza antipopulista perché se non ci andiamo noi con Macron poi ci vanno i Cinquestelle! Ah, qua la cosa è grave ma non è seria! E non basta che gli diciamo più sinistra, più uguaglianza in astratto… Io lo so, ci dicono: dovete essere concreti. Non sanno con chi stanno parlando. Qui in molti lo facciamo da anni. Provo a dirlo guardando alle cose che conosco. Il voto al Sud meriterebbe un seminario ad hoc, così come il voto al Nord. E magari lo faremo.
La Seconda repubblica finisce come era iniziata, con un’Italia divisa in due sul piano economico, sociale, politico. Ma i 5S non hanno raccolto al Sud solo sofferenza sociale e insofferenza politica. C’è stato un voto trasversale: disoccupati e professionisti, forconi e intellettuali, maestre e imprese. Segmenti sociali che erano i nostri. Una vera alleanza sociale, che poteva essere la nostra, è diventata la loro.
Un popolo che si è ribellato, gente stanca di una “cittadinanza negata”. Negata dalla mancanza di reddito (e che vergogna, le risate sulle file ai Caf!). Negata da una malasanità che ti costringe a emigrare anche per un’operazione banale. Dalla viabilità secondaria che è un pericolo costante per i cittadini e le imprese. Da un’alta velocità che si è fermata a Eboli. Da un’università penalizzata che non offre più opportunità ai figli, che allora emigrano già per proseguire gli studi. Se parliamo di investimenti pubblici in astratto, non ci capiremo mai. Se parliamo di cosa significa per le persone, torneranno a capirci, a sentirci vicini, prossimi. Al Sud, e non solo al Sud, non ricostruisci un rapporto con il popolo se non parti dai bisogni. Non dobbiamo fare comitati per il centrosinistra, non vuol dire niente. Dovremmo farli per l’acqua, per gli ospedali, per gli asili, per le strade, per l’ambiente. È così che formeremo anche una nuova classe dirigente! Perché la nostra è una parte essenziale del problema. Non solo ha fallito personalmente, ma ha travolto la credibilità delle istituzioni. Al Sud, destra e sinistra sono spesso vasi comunicanti, basta vedere le liste alle amministrative e le liste alle politiche (c’era uno che entrava di qua o entrava di là a Cosenza, suo nonno si rivolta nella tomba). Potentati senza potere, che pensano di muovere clientele costruite sul ricatto. Tutto questo ora è saltato. E qui io intravedo uno spazio, in cui provare a inserirci.
C’è stato un voto libero, non solo di protesta. Hanno votato per cambiare tutto, ma il ricambio non c’è ancora. Io credo che sia stato questo tema della classe dirigente a trasformare una sconfitta storica in una disfatta senza proporzioni.
Interroghiamoci sulla rapida ascesa e il repentino declino renziano. L’idea volgare della rottamazione rispondeva a un bisogno reale: “far saltare il tappo”. I giovani ci speravano, e alle europee un po’ ci avevano anche votato. Una volta al potere, i giovani sono apparsi come quelli che li avvitavano ancora più stretti i tappi. I loro riferimenti? Università private, banche d’affari, speculatori finanziari, società di consulenza, o al massimo le società di comunicazione. E una Confindustria che non rappresenta più nemmeno i suoi, già impegnata ad accreditarsi coi nuovi vincitori. I giovani renziani al potere per l’Italia erano e sono l’establishment e non smetteranno di esserlo. Un establishment che se la prende con istituzioni come la Banca d’Italia, o persino con Mario Draghi, cos’è? Uno scherzo? Grottesco. Élite in negativo, e non élite in positivo (come le intendeva Bobbio): questo è stato il Pd renziano. Hanno fatto la polemica sul curriculum di Di Maio. La politica non si fa col curriculum: ma, scusate, qual era il loro curriculum? Qual è quello di un Luca Lotti? O di quel nugolo di trasformisti e famigli vari che ha raccattato nelle liste elettorali. Chiediamocelo anche noi. “Quali sono i nostri libri? Abbiamo studiato”?
Se vogliamo farci capire, essere semplici, senza cedere alla brutalità, non dobbiamo studiare di meno. Dobbiamo studiare di più. Non lo studio delle biblioteche, che pure non guasta. Uno studio vivo, fatto sporcandosi le scarpe. Con passione. Con umiltà.
L’umiltà di cui parla Franco Cassano in una straordinaria rilettura della Leggenda del Grande Inquisitore. L’umiltà non è dire che “il popolo ha sempre ragione”, è riuscire ad accostarsi alle “zone grigie” della società. Responsabilizzare ampie fasce della società, ripoliticizzarle. Fuori da qui, dai nostri convegni, da Roma. Qui è il senso del fare opposizione. Che è diverso dallo stare all’opposizione, aspettando un cadavere che non passerà, perché il cadavere è già passato, eravamo noi. Chi rappresentiamo, oggi? Il Pd era l’unico partito rimasto. Lo è ancora? Quella notte delle liste, ci siamo comportati come Forza Italia, come la Lega, come la Casaleggio. Renzi ha fatto quello che voleva. Ma se ci fosse stata una classe dirigente, degna di questo nome, non sarebbe dovuto accadere. Rispetto per le minoranze, regole interne, statuto… è saltato tutto. Pensate alla parità di genere. Una vergogna. A proposito, voglio dirlo: io non lo so se organizzeremo altri appuntamenti con questa sigla. Ma se lo faremo, mi prendo un impegno, per tutti: che ci sia un servizio di baby-sitting. Vi sembrerà poca cosa, ma io non accetterò più persone che mi dicono non vengo perché non so a chi lasciare i bambini, e non tollero che a dirlo siano sempre e solo le donne! Il tema oggi è come consentire, quello che vuole la Costituzione: e cioè la libertà per i cittadini di partecipare alla vita democratica.
La soluzione non sono scorciatoie leaderistiche, primarie dove abbiamo più votanti che alle elezioni, perché diventano strumento di autoconservazione di piccoli e grandi cacicchi. Abbiamo bisogno di una disciplina dei partiti, che garantisca la democrazia interna. E questa è una necessità ancora di più oggi al tempo dell’algoritmo.
Vogliamo sapere tutto della Casaleggio, ma il problema è più generale. Perché oggi, nella debolezza dei partiti e nell’opacità dei loro meccanismi di funzionamento, dominano interessi più o meno legittimi, lobby senza nome, spesso le mafie. Le mafie. Perché poi i populisti, sono sempre gli altri: ma noi, che abbiamo abolito il finanziamento pubblico, che cosa siamo? Io penso che questa sia stata la peggiore classe dirigente di sempre e non perché ci ha fatto perdere così tanto, ma perché ci ha lasciato così poco da cui ripartire. Noi oggi proviamo a ripartire. E vogliamo farlo con una nuova generazione di studiosi, di militanti. Una generazione che ha resistito agli errori di altri, senza neppure aver luoghi per dire la sua. Non è un fatto anagrafico, perché c’è una comunità dispersa di tutte le età.
Siamo un esercito sconfitto, e senza “gradi”. Perché quelli che li avevano li hanno persi in battaglia. E questo vale per tutti, maggioranze e minoranze, democratici e fuoriusciti, parlamentari, amministratori e militanti.
Riprendiamo a discutere insieme, da capo. Per questo voglio ringraziare i dirigenti che hanno e hanno avuto responsabilità importanti, che hanno accettato di essere qui. Abbiamo pensato Sinistra Anno Zero come uno spazio aperto. Un luogo in cui confrontarci, anche duramente. Ognuno continuerà i suoi percorsi, nei partiti, nei sindacati, nelle realtà in cui vive. Questo vuole essere uno spazio in cui incontrarci. In cui abbandonare quello che a sinistra è un vizio antico e che Freud chiamava il “narcisismo delle piccole differenze”. Proveremo a fare il punto su questa giornata, offrirlo ai tanti che oggi non sono qui e che ci hanno chiesto di continuare. Proveremo a trovare un canale di comunicazione con tutti. Trovare parole comuni per i problemi di oggi. Rieducarci alla lotta politica. Alla lotta, questa parola che muove il mondo e che noi ci siamo dimenticati. Senza le tifoserie, i settarismi personali di questi anni. Abbiamo bisogno di libertà e di coraggio. La libertà di dare valore anche a quello che i soldi non possono comprare. Questa è la sinistra. Il coraggio di pensare con la nostra testa, di agire dove si svolge la vita, covano i disagi e le cose nuove. Ma non cadremo mai alla trappola della contrapposizione tra vecchio e nuovo. Ci preme capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E noi dobbiamo scegliere ciò che è giusto, anche quando non è facile.
[Foto in evidenza: Sinistra Anno Zero, la relazione di Giuseppe Provenzano. Roma, 7 aprile 2018]