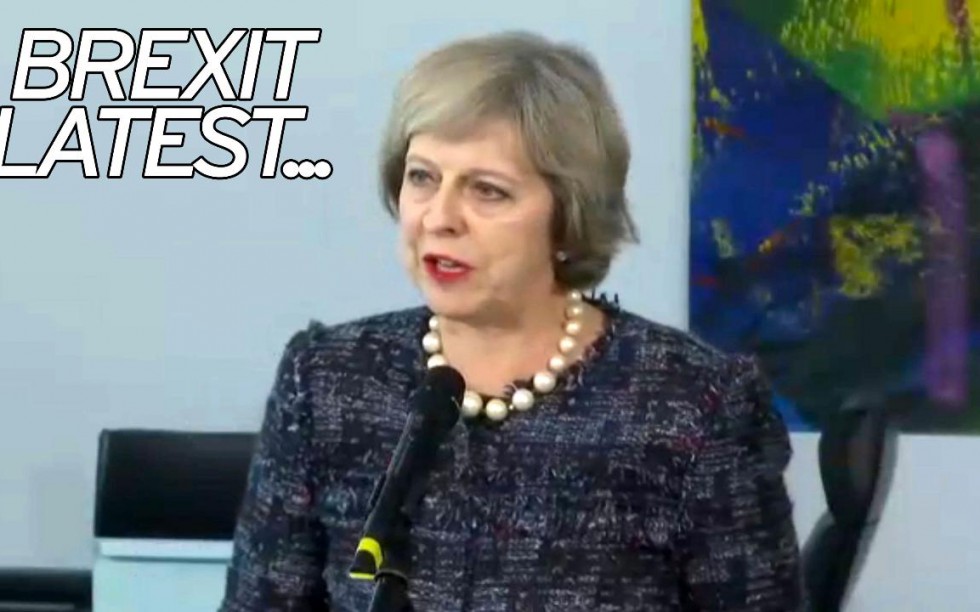Quasi un anno fa, il 20 febbraio 2016, il primo ministro, David Cameron, a conclusione di un consiglio dei ministri movimentato, annunciava la data del 23 giugno per il voto al referendum sull’adesione all’Unione Europea. I sondaggi, riportati dal Sole 24Ore di quel giorno, avevano colto esattamente quello che sarebbe stato il risultato effettivo: 52% per la Brexit e 48% contrari.
Un risultato determinato in buona sostanza dai più anziani; i giovani hanno votato in maggioranza per il “remain” ma molti hanno disertato le urne; Inghilterra e Galles per uscire dall’Europa (eccetto Londra); Scozia e Irlanda del Nord per restare. Un voto determinato da ragioni profonde: contro la City e Londra, per la concentrazione di ricchezza in quell’area e i divari economici rispetto al resto dell’isola; contro l’austerity per risanare i conti pubblici, dopo il salvataggio delle banche, travolte dalla crisi. La protesta verso la UE, a parte la contabilità su quanto la Gran Bretagna versa rispetto a quanto riceve, nasceva soprattutto dal desiderio di controllare e limitare i flussi migratori, anche dall’Europa.
La Brexit è stata la vittoria dell’ideologia in un paese pragmatico; il risultato di una lotta interna tra i Tories, nella quale hanno prevalso i più euroscettici, che hanno saputo usare la retorica contro l’immigrazione per spezzare il legame con la UE. Hanno vinto le tendenze, ancora presenti negli elettori anziani e conservatori, all’isolazionismo e le nostalgie dell’impero e dei tempi in cui la Gran Bretagna era una grande potenza. Cameron pensava di frenare la crescita dell’UKIP, guidato dall’eurodeputato Neil Farage, concedendo il referendum, convinto che la vittoria del “remain” avrebbe ricompattato il partito. L’esito è stato, invece, diverso e, come nella vittoria di Donald Trump alle presidenziali USA, le élite politiche non hanno capito le reali opinioni dei cittadini, specie di quelli della periferia. Una situazione aggravata dalla strategia basata sulle immediate conseguenze negative in caso di vittoria del leave sia in Gran Bretagna o sia di Trump in USA. Gli effetti della Brexit inizieranno nel medio-lungo termine, una volta definiti i rapporti con la UE, effetti che potranno indebolire il potenziale di crescita dell’economia e la riduzione del peso del Regno Unito nel panorama mondiale.
La Brexit ha colto impreparati tutti. Da qui il terremoto politico, con le dimissioni di Cameron, la nomina di Theresa May a premier e un nuovo governo, guidato dai ministri più antieuropei.
“Brexit means Brexit” ha subito affermato Theresa May, ma nessuno sa cosa si intenda con questo termine, ad esclusione dell’impegno a rispettare la volontà espressa dal voto.
Ciò spiega l’estrema cautela nell’attivare l’art. 50 del Trattato di Lisbona che farebbe scattare i due anni previsti dal Trattato per l’uscita di uno Stato Membro. Ma la complessità e profondità dei rapporti tra il Regno Unito alla UE (si tratta di circa 12.000 norme) potrebbe richiedere un periodo più lungo, che alcuni stimano da cinque a dieci anni.
Per un paese in cui la certezza del diritto e la semplicità delle regole sono la base, le incertezze sulla transizione preoccupano imprese e mercati, soprattutto dopo le dichiarazioni di diverse grandi aziende straniere sull’impatto negativo di una Hard Brexit su crescita e occupazione.
Theresa May, il 17 gennaio scorso, con un discorso duro nella forma, ha illustrato la posizione del governo sulle trattative con l’Unione, prospettando un divorzio di Londra tempestoso. La premier ha persino minacciato di trasformare l’Inghilterra in un paradiso fiscale.
Nel frattempo, il nuovo Presidente degli Stati Uniti, finora i migliori alleati dell’Europa, si è augurato la dissoluzione dell’Unione, stravolgendo 70 anni di diplomazia di Washington e dando copertura a chi è tentato di seguire la Gran Bretagna. Insomma, il 2017 si presenta difficile e pieno di incertezze.
La decisione della Corte Suprema che l’avvio dell’uscita deve passare dal voto del Parlamento è stata un duro colpo per il Governo britannico, che ha perso definitivamente la battaglia legale contro Gina Miller, la donna d’affari promotrice del ricorso per chiedere che fosse il parlamento a deliberare sul referendum. Una sconfitta importante, le cui conseguenze pratiche non sono ancora chiare. Di certo, il Parlamento non ribalterà il risultato del voto, ma la sentenza potrebbe dilatare l’avvio della procedura di uscita. Il Parlamento potrebbe anche dare indicazioni più chiare al Governo, il cui atteggiamento è contraddittorio: vuole i vantaggi dell’Unione senza pagarne le spese; vuole modificare a suo vantaggio le regole tenendosi però l’opzione di uscire del tutto. La stampa popolare continua ad alimentare le aspettative, forte dell’assenza delle conseguenze negative a suo tempo previste dagli esperti.
Dal discorso di Theresa May emerge, innanzitutto, la voglia di mettersi nella posizione negoziale migliore, dicendo all’UE “non abbiamo bisogno di voi”. Oggi, infatti, l’economia britannica è in buona forma, la disoccupazione è ai minimi, nonostante il libero accesso degli immigrati europei, le sacche di povertà sono relativamente silenziose, i mercati valutario ed azionario tengono.
Tuttavia, poiché i rapporti di forza nel medio periodo potranno cambiare, dire “non abbiamo bisogno di voi” vale solo come posizione negoziale. Un altro punto dell’intervento di Theresa May è la promessa di cercare il risultato migliore per il paese. Con affermazioni generiche del tipo: “rafforzeremo l’unione con la Scozia” e “non costruiremo blocchi di frontiera con l’Irlanda” che rimane membro della UE. E altre come: “speriamo di ottenere il miglior risultato possibile per i cittadini che già si trovano nel Regno Unito”. Insomma, la premier si lascia aperta ogni strada, con altre contraddizioni del tipo: “non vogliamo immigrazione incontrollata”, “ma ogni immigrante individuale sarà sempre benvenuto come un vero amico”. “Rafforzeremo le leggi UE per dare più diritti ai lavoratori” dopo aver dichiarato di voler “rigettare l’autorità della Corte di giustizia dell’Unione europea”, perché “il parlamento di Westminster è sovrano”, salvo opporsi, perdendo contro il ricorso della Miller, a che i deputati votino sull’attivazione dell’articolo 50.
Insomma, nonostante le promesse di chiarezza, nessuno sa in che modi e in quali tempi si perfezionerà la Brexit.
L’impressione che siamo agli inizi di un percorso negoziale molto lungo, alla fine del quale poco cambierà nel rapporto tra la Gran Bretagna e l’Unione Europea, inizia a prendere consistenza.