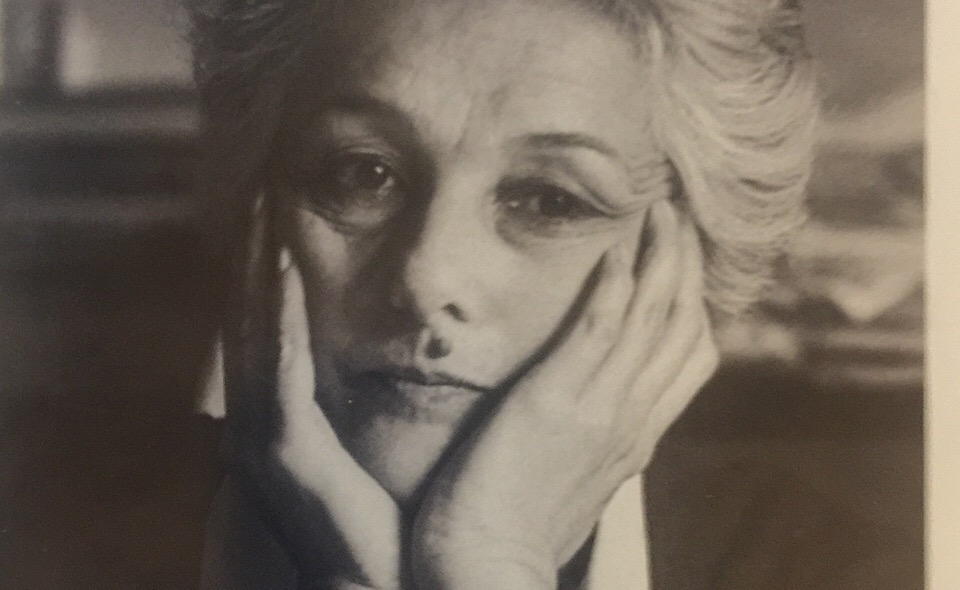
Il “socialismo che si fa in tutti e ciascuno come liberazione”. L’eresia di Rossana Rossanda
In memoria di Rossana Rossanda. Col concludersi del
“secolo breve”, la fine del comunismo e la svolta della
globalizzazione, Rossana Rossanda ha sempre rivendicato
di appartenere al suo tempo e insieme non ha mai smesso
di interpretare, di afferrare, di comprendere i nodi di
un’altra contemporaneità – che nasceva sotto i suoi occhi.
Come per offrire un canone di lettura della propria
biografia, ha ripetuto più volte che era diventata militante
comunista per “scelta”, condividendo nel partito “nuovo”
di Palmiro Togliatti, disciplina, rigore di analisi e cecit�
ideologica. Qualche anno prima del ‘56 fu Annamaria
Ortese in viaggio col suo Treno russo che cominciò a farle
sospettare, tra polemiche, litigi e abbracci, della realt�
dello stalinismo (A. Ortese, La lente scura, Milano,
Adelphi 2004).
Autrice e militante, ha respinto con fermezza la
mitizzazione della propria figura, della propria opera ed è
intervenuta, in continuità con se stessa, sui nuovi orizzonti
politici e di studi che nel frattempo si erano aperti (ricordo
emblematicamente la posizione presa in merito alle ricerche di Marcello Musto studioso del marxismo, un
“cervello in fuga” da Napoli a Toronto).
Va sottolineato con forza che la sconfitta storica del
comunismo non l’ha intrappolata nella diaspora della
sinistra e nel vicolo cieco delle sue identità. Forse la
filosofia, l’insegnamento di Antonio Banfi non glielo
potevano permettere. La vocazione politica la spinse, con
la fondazione del “Manifesto” a fare da “ponte” tra la
“saggezza della vecchia sinistra” e le “idee giovani” che si
erano prospettate col ’68.
Politica e autobiografia. Agli inizi degli anni 2000 aveva
definito se stessa, nella propria autobiografia, la ragazza
del secolo scorso, raccontando la contemporaneità a cui
apparteneva e quasi documentando e circoscrivendo nel
testo di qualche anno più tardi (Quando si pensava in
grande. Tracce di un secolo, Torino, Einaudi 2013),
lo spazio teorico dentro al quale era intervenuta: Lukacs,
Sartre, Althusser, Paul Sweezy, Salvador Allende, Bruno
Trentin, i grandi intellettuali e dirigenti del secondo
Novecento con i quali aveva condiviso il progetto di
cambiare il mondo e di cambiare la vita. Aveva conosciuto
a Parigi ,negli anni in cui abitò con Karol Kewes Karol,
Michel Foucault: “un’intelligenza di primordine”, in
assoluto contrasto con Sartre.
Non si era tirata indietro nemmeno nel contestualizzare
l’impasse del terrorismo nel clima sociale degli anni ’70.
Indicando con rigore che l’aria di famiglia delle Brigate
rosse non poteva scalfire il senso critico del comprendere
(Cft. Brigate rosse. Una storia italiana, Milano, Mondadori
2007).
La sinistra e la storia. Non ha mai ceduto alla “malinconia”
di un sinistra vinta e ha interpretato la propria formazione
intellettuale e militante come espressione di avanguardia,
di un marxismo critico, “occidentale”, sorto su base
eurocentrica.
Nella tradizione comunista ha fatto parte e ha dato voce
ad una sinistra eretica, aperta, avversaria di ogni censura.
Era rimasta colpita dalla particolare esperienza della
Resistenza, in Germania, della “Rosa bianca” e dichiarò di
aver amato la “lezione di laicità” di Dietrich Bonhoeffer – il
suo pensiero filosofico-religioso e la sua passione politica,
su cui ha scritto.
—
Foto in evidenza: Rossana Rossanda (dalla copertina del libro “La ragazza del secolo scorso”, Einaudi, 2005



