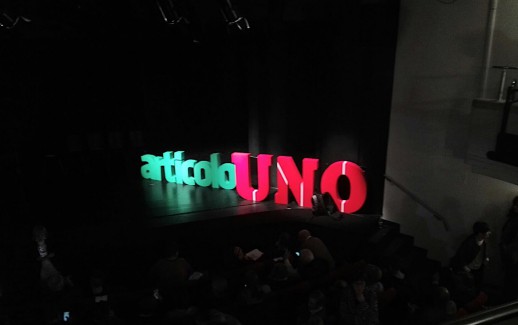La separazione da un percorso politico (o disunione) è frutto di una razionale analisi comparativa tra scenari. Tra un’ipotesi di continuità e appartenenza, di disciplina di partito, di accettazione delle decisioni dall’alto e di perimetrazione dell’azione politica al consentito, e un’ipotesi di coerenza con i contenuti politici, ormai in contrasto con la filiera decisionale prevalente. I richiami alla coesione, a “ricucire la scissione”, avrebbero avuto un valore se avessero considerato anche come affrontare questo secondo punto, ma è evidente che sarebbe stato incompatibile con la studiata deriva “persuasivista” del partito.
Vorrei fare un passo indietro e tornare a qualche anno fa, quando ho sentito l’urgenza di ripensare alla mia partecipazione politica. Avevo assistito a una conferenza sulle modifiche costituzionali allora in divenire: si elencavano provvedimenti, giustificati con l’immediata necessità di ottimizzare i processi. Provvedimenti che però assemblati mostravano il rischio di erodere pesantemente la rappresentanza dei cittadini. Questo è stato ed è oggi il senso del mio impegno: riportare la politica a una dimensione diffusa, dialettica, dinamica, plurale.
Di questi tempi si fa un gran parlare di populismo, un vocabolo che mette a tacere ogni contenzioso quando si sollevano obiezioni sulle alleanze indigeste. Eppure non dobbiamo dimenticare che il populismo si nutre di leaderismo, di uomini forti al comando, di disintermediazione tra cittadini e istituzioni. Abbiamo vissuto un periodo di progressivo abbandono dei presìdi di rappresentanza sul territorio, dalle circoscrizioni alle province. La mia ferma opposizione alla riforma costituzionale ha preso i passi da una semplice convinzione: non era sopportabile un’ulteriore sottrazione di democrazia. La distanza tra cittadini e istituzioni è diventata drammatica, e in nome della governabilità a qualsiasi costo non si può più sacrificare in alcun modo la rappresentatività.
Qui entra in gioco anche l’idea partito: negli ultimi anni abbiamo visto affermarsi una visione del partito come una serie di diverse posizioni che tentano via via di comporre decisioni in modo puntuale su questioni particolari (spesso ricorrendo alla disciplina di partito, o alla fiducia parlamentare), essendo impraticabile una sintesi di livello superiore. Un irrisolto nei contenuti, che ha bisogno di un leader mediatico per resistere alle prove elettorali.
Il risultato è un orizzonte di elaborazione politica sempre più ristretto, che limita il potere rappresentativo della base e dell’elettorato, chiamati ad appuntamenti obbligati e a un consenso mai veramente metabolizzato. Penso alle parole d’ordine e agli slogan della campagna referendaria, degenerati in vera e propria demagogia, ancora più imbarazzante per chi come me è convintamente federalista europea.
Oggi più di sempre invece c’è bisogno di spostare l’attenzione su temi politici alti e coinvolgenti, di interesse collettivo. Principi cardine su cui un partito deve avere una voce riconoscibile, chiara e progressista, libera da etichette correntizie affibbiate solo per eludere il dibattito. Serve un partito che abbia una linea non subalterna rispetto al mondo della finanza e dell’impresa, un partito che abbandoni le pratiche liberiste che in questi anni hanno mietuto vittime e alienato relazioni con parti sociali fondamentali, primi su tutti i sindacati.
Io credo nella sinistra. Una sinistra che esiste e che deve ritornare a esprimere la sua universalità, la sua vocazione a rappresentare i più deboli. E a dare voce a quelle forze che non possiedono mezzi economici o mediatici, ma che sanno di poter trovare idee e risposte nel processo di rappresentanza politica e democratica, e nella partecipazione attiva alla vita politica. Perché l’unica risposta a al populismo è più democrazia.
—
Nella foto di copertina: Silvia Prodi, consigliere regionale dell’Emilia Romagna, ad una manifestazione per la Festa della Liberazione