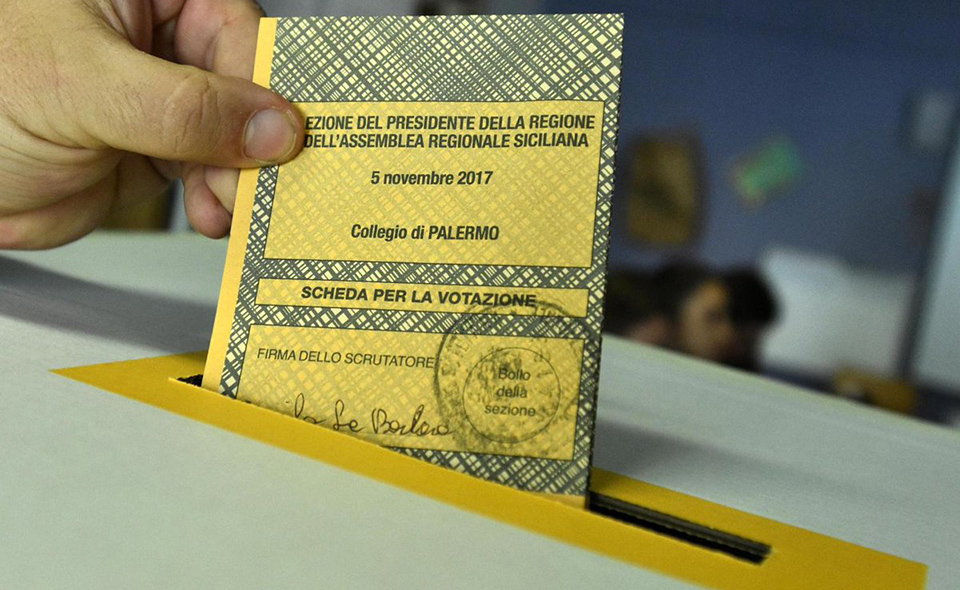
Una sinistra “aperta”: la questione dell’identità in margine al test siciliano
1 ) Dieci anni di PD
Ma veramente dopo il test siciliano e il penoso attacco di Davide Faraone al Presidente del Senato Grasso si può dire che il PD, nel decimo anno della sua nascita “non è mai esistito”, secondo la tesi di Massimo Cacciari; o è semplicemente “un esperimento fallito”, secondo quanto si legge nelle analisi di altri osservatori (M. Prospero, Il Manifesto (15/10/2017)?
Non è forse preferibile interrogarsi, come ha fatto nel suo libro e dal suo punto di vista, Piero Fassino su un “PD davvero” (Milano, La nave di Teseo 2017) e analizzarlo per le sue vicende, anche quelle siciliane e in vista dell’eventuale appuntamento costituente di novembre ?
Fassino almeno non si chiede, al pari del filosofo puro – irriso da Benedetto Croce – se il PD esiste fuori di sé o dentro di sé, ma da protagonista ne indica i limiti, i successi, perfino difficoltà di fondo condivisibili, come l’incapacità di “fornire una guida democratica alla globalizzazione”. Una volta ammesso che il PD esiste si può pure convenire con il siciliano Emanuele Macaluso che “…., è un agglomerato elettorale senza più cultura politica” (Il Manifesto, 28/10/2017).
Peraltro le trasformazioni del PD sono state più volte osservate e narrate, prima delle elezioni siciliane, da storici e studiosi delle scienze sociali. Su quest’ultimo versante i titoli non mancano. Il PD come partito pragmatico che ha preso il posto del partito “ditta” di Bersani è stato analizzato in un recente e notevole lavoro (Cfr Paolo Natale e Luciano M. Fasano, L’ultimo partito, Dieci anni di partito democratico, Torino, Giappichelli 2017). Così come è stata focalizzata con grande acutezza la svolta impressa al partito dal gruppo dirigente che ha sostenuto la leadership di Matteo Renzi (Cfr Massimo L. Salvadori, Lettera a Matteo Renzi, Roma, Donzelli 2017). Lo stesso smarrimento elettorale delle regioni “rosse” è stato esplorato da Mario Caciagli, (Cfr “Addio alla provincia rossa. Origini, apogeo e declino di una cultura politica” (Roma, Carocci 2017). e la “cronaca” delle vicende niente affatto irrilevanti dell’identità di sinistra, su cui si costituisce il PD , si può rapidamente scorrere in un lavoro di Paolo Bellucci, Marca Maraffi, e Paolo Segatti, (PCI, PDS, DS .La trasformazione dell’identità politica della sinistra di governo, Roma, Donzelli 2000).
2 ) Le identità di sinistra
Ciò che variamente si palesa in queste analisi è un medesimo risultato che sembra in movimento col test siciliano e che riguarda l’identità multipla della sinistra. Il PD a dieci anni dalla sua nascita “ è diventato un partito …la cui ideologia in senso lato è il liberalismo di sinistra” (Michele Salvati, Il foglio 4 ottobre 2017). La sua prefigurazione in una grande coalizione con la destra, si regge su questo collante. Anche sulla base dei dati siciliani: si esprime legittimamente, nel suo gruppo dirigente, nella sua base e nella sua leadership. Si parla correttamente di nativi PD .
Il problema che si pone con questa “ideologia” e con la constatazione della sua “agglomerazione” (Macaluso) sta tutto nel tratto indicato da Salvati.
Se si vuole, è il limite di una sinistra priva delle altre componenti, per l’appunto una sinistra più povera, più chiusa, soltanto “liberal”. Un limite che storicamente, si manifesta in Italia fin dall’origine della “questione sociale” nelle riflessioni eminenti sul rapporto tra libertà ed eguaglianza (Cfr C. Rosselli, Socialismo liberale, a cura di J. Rosselli e con scritti di N. Bobbio, Torino, Einaudi 2009). Riflessioni considerate, peraltro, oggi, in chiave schiettamente neoliberistica da esponenti di primissimo piano del PD per i quali è l’”equità” che va messa al posto dell’ “uguaglianza” (cfr. Y. Gutgeld, Più uguali più ricchi, Milano, Rizzoli 2013).
La cosa non è da poco, Gutgeld sembra mettersi al posto di Bobbio. Sullo sfondo di questa modificazione e l’emozione del testo siciliano, non si può, efficacemente e senza retorica , non rivendicare, che comunque la ricchezza della “matrice di sinistra”, compresa quella liberal , alla base della nascita del Pd risiedeva nel “riformismo che puntava all’ uguaglianza” (Sergio Cofferati) . Era un riformismo che ritrovava “una nuova identità…. storicamente fondata” per riprendere Reichlin, mettendo “assieme due storie diverse ma convergenti, quella del riformismo socialista e comunista e quella del cattolicesimo, unendole con esperienze più recenti come l’ambientalismo e i movimenti”. (Sergio Cofferati, Il Manifesto 15/10/2017).
Di fatto la sinistra “pragmatica”, soltanto liberal nel PD perde, non solo in Sicilia, perchè si allontana da questo riformismo: lo mette in discussione, lo neutralizza, lo delimita e lo esclude. Considera la “matrice di sinistra”, insieme alle sue storiche ragioni e alle sue storiche utopie, come il male italiano. Le convergenze tra le tradizioni comunista, socialista, del partito d’azione, del cattolicesimo di sinistra, dell’associazionismo, così proprie della cultura meridionalistica, sono assunte come segno irrevocabile del disorientamento delle masse e della crisi identitaria della politica.
Sta forse tutto qua il senso della sconfitta siciliana del PD. Il “sacrificio” della rappresentanza a favore della governabilità si sposa bene, di volta in volta, con una politica economica che ricade pesantemente sul “sociale”. La disgregazione dei gruppi subalterni, polverizzati nei loro diritti viene riconosciuta programmaticamente secondo una visione individualistica: la “compassione” verso i deboli, e la loro condizione “minoritaria” di “vinti”, di “esclusi” dalla cittadinanza e dal lavoro ( cfr Franco De Benedetti, Sceglere i vincitori, salvare i perdenti, Venezia, Marsilio 2016).
3) Identità di sinistra e storia d’Italia
E’ certamente messa in questione nella politica “pragmatica”, individualistica del PD, la rappresentanza sociale del lavoro. La razionalità mezzi-fini con cui si subordina il lavoro al sostegno dell’imprenditoria assume sempre di più i tratti formali di una ragione strumentale avversa alle possibilità e all’orizzonte di una reale “civilizzazione” del “sociale” nell’ ambito dell’ economia globalizzata.
Non a caso nella sua intervista /manifesto La rivoluzione socialista, Enrico Rossi parla di un socialismo del futuro e parimenti rivendica le migliori tradizioni della sinistra inscritte nella storia d’Italia. E’ probabilmente tenendo conti di questi due versanti che si può pensare, per l’appuntamento costituente di novembre, ad un partito oggi nuovo, distinto identitariamente sia dal neoliberismo progressista, sia dal populismo antisistema: un partito che dovrà misurarsi, non solo con la sua organizzazione ma anche con le sue interne “nostalgie” e “testimonianze” . Forse bisognerebbe riprendere con più forza la speranza di Reichlin per raggiungere una capacità di seguito larga e praticare una lotta (una “guerra di posizione”) appropriata ai processi contemporanei, come richiedono insistentemente i sindacati, i nuovi movimenti globalizzati e come avveniva, in un altro presente, nei movimenti politici del secolo scorso, non solo nel ’68 (Cfr Nadia Urbinati, La mutazione antiegualitaria Roma-Bari Laterza 2013).



